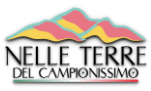Il Comune di Grondona è localizzato in Valle Spinti ed è il principale centro abitato di questa vallata in cui scorre il Torrente Spinti, tributario del Torrente Scrivia.
Il toponimo venne citato per la prima volta in un documento durante le conquiste da parte del Sacro Romano Impero guidato da Federico Barbarossa nel 1164, scritto in cui si sottoponeva Grondona al Comune di Pavia prima di essere integrata, nel corso del 1176, tra i domini del Comune di Tortona. 5 anni dopo, su commissione dei Vescovi tortonesi, venne costruito il Castello di Grondona su una posizione elevata rispetto all’odierno paese elevata. Tutto ciò venne realizzato a scopo difensivo e di controllo sull’area della Valle Spinti e venne utilizzato fino al 1797, anno in cui Grondona entrò a far parte della Repubblica di Genova dopo diversi secoli di dominio da parte della famiglia Malaspina. Ciò che possiamo ammira oggi del castello è solamente un mastio poiché una tragica frana avvenuta il 23 aprile del 1934 portò con sé gran parte dell’antica fortezza, travolgendo le abitazioni sottostanti e provocando una decina di morti. La torre oggi è ben visibile arrivando a Grondona dato che si eleva sul Monte Asserello ed è un’importante testimonianza del passato di questo borgo.
Tornando alla storia del paese, Grondona restò sotto il controllo di Tortona fino al 1259, anno in cui ottenne la propria indipendenza a seguito della sua costituzione come Comune autonomo, governato dal podestà Federico da Grondona il quale controllava in questo periodo i feudi di Dernice, Magioncalda (Frazione di Carrega Ligure) e Roccaforte Ligure. La propria autonomia durò fino l 1294 dato che il futuro Vescovo di Tortona, Percivalle Fieschi, acquista parte del feudo, diventando così di dominio della famiglia dei Fieschi fino al 1457, anno in cui Grondona passò ufficialmente al Ducato di Milano a seguito del giuramento di fedeltà avvenuto nel 1433 da parte di Nicolò Fieschi nei confronti della Famiglia Visconti di Milano. 14 anni dopo, nel 1471, Grondona tornò ai Fieschi mentre nei successivi anni fu un susseguirsi tra la famiglia Doria, i quali entrarono in possesso del feudo dal 1547 fino al 1560, anno in cui passò definitivamente ai Malaspina fino all’arrivo delle truppe Napoleoniche.
Oggi, all’interno dei confini comunali di Grondona, possiamo ammirare alcune architetture religiose di particolare bellezza, inserite in un contesto paesaggistico prevalentemente coperto da boschi di faggio e castagno. La prima di tutte è sicuramente la Chiesa dell’Assunta originaria del 12º Secolo e ampliata nel corso del 17º e 18º Secolo. Si tratta di uno splendido esempio ben conservato di romanico, mostrando anche diverse parti originarie della prima edificazione.
Poco prima di arrivare al centro di Grondona, in prossimità della Frazione di Variana giungendo da Arquata Scrivia percorrendo la strada provinciale, si noterà sicuramente la Torre di San Colombano, architettura risalente al 17º Secolo realizzata in laterizio facente parte dell’antica Chiesa di San Colombano. La costruzione era difatti la sua torre campanaria come si può chiaramente notare dalle sue aperture nei pressi della sua sommità.
Alle porte di Grondona, sulla strada che conduce alla Frazione di Sezzella, è presente un’altra testimonianza di romanico-gotico del borgo: la Chiesa dell’Annunziata. Di essa non si hanno particolari informazioni sul periodo preciso in cui è stata realizzata e conserva al suo interno splendidi affreschi prodotti tra il 15º e il 16º Secolo.
Altre interessanti architetture religiose sono la Chiesa di San Rocco, situata nel centro storico di Grondona, la Chiesa di Sasso nella Frazione di Sasso di Sotto e la Chiesa di San Pietro Apostolo del 17º Secolo della Frazione di Lemmi, splendida località a cavallo tra la Valle Spinti e la Val Grue.
Per gli amanti della natura, soprattutto della bicicletta, percorrere la strada che collega Grondona a Roccaforte Ligure è una dura impresa che ripagherà i vostri sforzi con uno strepitoso panorama, tra la Valle Spinti e la Val Borbera, che garantirà un’ampia visibilità sulle vette degli Appennini, sulla pianura Padana e, nelle giornate più limpide, sulle Alpi.